Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Da Kosovo_Roma
TRANSITIONS ONLINE: by Jessica Meyers - 26 February 2007 (* riassunto lunghetto - meglio leggerlo offline)
MITROVICA, Kosovo - Saffet Ramic ha imparato dai tempi della guerra a viaggiare con un cacciavite.
In una polverosa strada di Mitrovica, tira il suo carro a lato della strada. Poi tira fuori il cacciavite dalla sua tasca destra. Svita le targhe con la registrazione del Kosovo e le pone all'interno.
"Così i Serbi non ci uccidono" dice semplicemente. E' concesso girare senza targhe in questa parte della città, visto che le targhe del Kosovo qui non sono accettate. Dopo diversi posti di blocchi, quando il carro torna in territorio albanese, riavvita le targhe.
"Così gli Albanesi non ci uccidono" dice Ramic, 30 anni, rivelando con la sua pelle color bronzo di non essere Serbo od Albanese, ma uno dei circa 30.000 Rom che sono parte dei 2 milioni di popolazione del Kosovo..
In una regione dove ad otto anni dal conflitto tra le forze serbe e gli Albanesi del Kosovo le tensioni etniche rimangono alte, Ramic naviga tra due mondi chiaramente definiti, anche se non appartiene a nessuno dei due. Come le targhe del furgone, Ramic svita ed avvita la sua identità secondo la necessità e convenienza.
Molti dei 150.000 Rom finirono in mezzo al conflitto del 1998-1999, quando erano considerati dagli Albanesi collaborazionisti dei Serbi, mentre l'armata serba li sgomberava dai villaggi dei kosovari albanesi. A migliaia finirono nei campi temporanei, dove sono tuttora. Oltre 120.000 lasciarono il paese prima dell'intervento NATO e della sconfitta dei Serbi, con il successivo protettorato ONU in Kosovo.
Come risultato del conflitto, molti Rom -termine a cui vanno aggiunti gli Askali di lingua albanesi e quelli che si chiamano Egizi - hanno adattato la loro identità per sopravvivere. Anche se Ramic si considera Rom, in qualche caso è più sicuro per lui dichiararsi Askali.
Rimane incerto quando la regione riguadagnerà abbastanza stabilità perché Ramic possa dichiararsi senza problemi e i Rom facciano ritorno alle loro case.
Si attende quest'anno un accordo finale, secondo il quale il Kosovo diventerebbe uno stato indipendente, un trionfo per gli Albanesi, ma una perdita devastante per i Serbi. In una terra dove tutti rincorrono una loro identità, i Rom - senza nazione e coesione - vivono sul punto di rottura. Molti chiedono soltanto di tornare a casa.
STORIA RIVISSUTA
Con l'indipendenza e possibili ulteriori violenze. i Rom sono impauriti, disillusi e stanchi di essere in mezzo ad una guerra che non gli appartiene. Per questa minoranza, lo status del Kosovo è solo un'altra occasione per vuote promesse ed ulteriori dispersioni.
Ramic annuisce ad un uomo in uniforme blu. Rallenta il furgone e si prepara a parlare albanese. Se il poliziotto è un Albanese, oggi Ramic sarà Askali. Il poliziotto guarda i documenti e riconoscendo la pronuncia di Ramic, gli si rivolge in serbo. Il Rom risponde con un sospiro trattenuto.
Diversi kilometri più tardi, il carro si ferma di fronte al ponte che connette la Mitrovica settentrionale alla sua controparte albanese del sud. "Non voglio andare da quella parte," dice Ramic guardando la simbolica divisione sul fiume Ibar. Parcheggia a diversi metri dal ponte ed aspetta.
Situata nella parte più settentrionale del Kosovo, il confine con la parte serba di Mitrovica è considerato una delle aree più a rischio violenza. In una città dove una divisione tangibile separa un'etnia dall'altra, tanti i Serbi a nord che gli Albanesi a sud, sono particolarmente sensibili sulle conseguenze della possibile indipendenza del Kosovo.
PRESI IN MEZZO
"Noi siamo il ponte ed ognuno ci passa sopra," dice un altro Rom, Dzafer Micini, 38 anni, seduto sul pavimento della sua casa di tre stanze a Kosovo Polje. Ricorda le rovine fumanti delle case dei suoi vicini, quando cinque anni fa gli Albanesi attaccarono la città.
Il villaggio è un obiettivo sensibile a causa della grande battaglia che nel Medio Evo vide l'esercito ottomano sconfiggere i Serbi, un evento che tuttora genera passioni nazionaliste tra i Serbi. I musulmani Albanesi sono visti come discendenti dell'oppressore Turco. L'enclave serba conta circa 15 famiglie Serbe e cinque case Rom. Micini teme che gli Albanesi vogliano bruciare il villaggio a predominanza serba e sta disperatamente cercando di vendere casa. Come molti Rom, d'altronde, non ha i documenti giusti per farlo.
"Non possiamo essere agnelli tra i lupi," dice, gettando uno sguardo al suo figlio più giovane che gioca con le decorazioni festive in un angolo. La nera stufa a legna riscalda la stanza vuota, illuminata dalla luce elettrica. Dice che si preoccupa di mandare i suoi figli al mercato. "Albanesi e Serbi sono falsi. Quando hanno bisogno di noi per combattere ci dicono fratelli. Se no, dicono 'Zingari, andatevene.'"
Micini è stato fortunato. Scappato in Serbia durante la guerra, la sua casa era una delle poche ancora in piedi quando ritornò al villaggio un anno dopo.
Quando ci furono i disordini nel marzo 2004, Micini non era a casa. Era a Pristina con diversi altri parenti maschi. Non poteva tornare da sua moglie e dai figli a Kosovo Polje, distante 12 kilometri e non vuole rivivere quel senso di impotenza per la terza volta. Se i Serbi che popolano il villaggio saranno forzati ad andare, dice, ai Rom non rimarrà altra scelta che partire pure loro.
Molti Rom ora vivono nelle enclave serbe, piccoli villaggi persi nel Kosovo dove il cirillico prende il posto dell'alfabeto latino usato dagli Albanesi. Durante il brutale decennio di Slobodan Milosevic che restrinse la libertà dei Kosovari albanesi, persino i Rom avevano diritti non concessi all'etnia albanese, che costituiva circa il 90% della popolazione.
Quando la Missione ONU in Kosovo (UNMIK) prese il controllo della provincia e stabilì un governo provvisorio guidato dai Kosovari albanesi dopo la guerra, i Rom si ritrovarono dispersi e disprezzati, incapaci di costituirsi come gruppo che rivendicava i propri diritti. Divenne soltanto marginalmente più sicuro identificarsi come Askali di lingua albanese.
In una regione popolata da Rom che si dichiarano Askali, la guerra e le continue violenze hanno creato una variazione nell'auto-definizione. Ora ne i Rom ne gli Askali sono realmente al sicuro. Tutti subiscono le conseguenze della guerra.
"Molti sono diventati Askali durante la guerra" dice Akif Mustafa, 48 anni, un Rom dell'enclave serba di Plemetina. Disegna un cerchio nell'aria. "Questo è il circolo del pane. Il pane si sta rompendo in pezzi," dice, simbolizzando la creazione dei Rom, Askali ed Egizi. "Ma, vedi, è solo del pane spezzato. Siamo tutti Rom e siamo sempre i più poveri."
INTOSSICAZIONE E RILOCAZIONE
I Rom sono il gruppo di minoranza più povero del Kosovo, agli ultimi posti nella scolarizzazione e col più alto tasso di disoccupazione. Oltre un terzo vive in estrema povertà, paragonato al 4% dei Serbi e al 13% degli Albanesi, secondo un rapporto del Programma di Sviluppo ONU.
Con pochi soldi e nessun posto dove andare, molti non hanno potuto lasciare la regione dove le loro case sono state date alle fiamme nel 1999. Quanti non hanno potuto andare in Germania o scappare in Serbia sono finiti nei campi ONU. Otto anni dopo, la maggior parte è ancora lì.
"Per gli Zingari è peggio adesso che durante l'Olocausto" dice Paul Polansky, fondatore della Fondazione dei Rifugiati Rom del Kosovo e studioso amatoriale dei Rom. Polansky recentemente ha condotto 100 interviste orali a Rom sopravissuti all'Olocausto e dice che l'attuale situazione per i Rom del Kosovo è una pari atrocità.
In nessun altro posto la sofferenza dei Rom in Kosovo è più evidente che nel campo per rifugiati inquinato dal piombo nella parte nord di Mitrovica.
Uno di loro, Cesmin Lug, si trova al limite della parte serba di Mitrovica. Cumuli di metallo, da cui ha origine il piombo, percorrono il campo di baracche di latta.
La casa di Sebiha Bajrami è dipinta di rosa e giallo. All'interno, due donne lavorano una pasta e la pongono sulla stufa che riscalda le due stanze. La loro è una delle 40 famiglie che hanno scelto di vivere nel campo contaminato, invece che nel nuovo campo dall'altra parte della strada. Chiamato Osterode, è la soluzione ONU alla contaminazione da piombo nei tre campi per i dispersi interni (IDP).
"A Cesmin Lug c'è inquinamento da piombo e a pochi metri c'è Osterode, ma è lo stesso" dice Bajrami, 35 anni, che non crede alle assicurazioni delle autorità che il campo di Osterode sarebbe più salubre. "Al limite a Cesmin Lug abbiamo l'acqua ed è più pulito, perché c'è meno gente e vengono fatte le pulizie." Nel campo ci sono attualmente 166 persone, comparate ai 43 di Osterode.
Lo scetticismo di Bajrami nasce anche dal fallimento dell'UNMIK nel recepire le preoccupazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) sui livelli dell'inquinamento nel 2000. La WHO ha ripetuto che l'esposizione all'aria, all'acqua e al cibo, porta a danni irreversibili al cervello. Le conseguenze sono più profonde per i bambini.
Bajrami, che è anche una giornalista rom per la locale stazione radio serba, ha contribuito alla creazione di un'organizzazione femminile che produce tovaglie e tessuti. [...] Ma la situazione interna non varia.
"Questo sarebbe il nostro quarto campo e siamo stanchi di tutti i campi," dice. "Vogliamo tornare alle nostre case, non Osterode."
Qui non è più salubre e sicuro. Quando Bajrami deve avventurarsi nella parte sud di Mitrovica, prende determinate precauzioni. Non si riferisce mai a se stessa come Rom e parla solo albanese.
Una volta, ricorda, fu accostata da un Albanese che aveva riconosciuto il suo nome. Era lei la ragazza che leggeva le notizie in serbo, le domandò. "Sì," rispose. "Sono la schiava che legge le notizie di altre persone. Trovami un altro lavoro da fare."
Bajrami spera un giorno di aprire una stazione radio rom, una che suoni musica rom tradizionale e si occupi di politica dei Balcani. Ma prima, come tutti nel campo, vuol fare ritorno a casa.
IL CICLO DELLA DIMENTICANZA
Una barriera con un pesante cancello, separa Bajrami e il resto di Mitrovica da Osterode, il nuovo campo dichiarato dall'UNMIK "libero da inquinamenti".
Una guardia albanese osserva dal suo piccolo chiosco. Riconoscendo il camion bianco della Norwegian Church Aid, apre il cancello senza le solite procedure e domande. La OnG norvegese ha preso in carico la gestione del campo, una serie di baracche bianche e un edificio più alto.
Nonostante i colori vivaci dei vestiti e delle tovaglie, il campo ha l'influsso austero di una base militare francese. L'asfalto sostituisce il fango dall'altra parte del cancello.
I genitori accompagnano i bambini verso il presidio sanitario, un edificio di due stanze. Qui è iniziato il trattamento per quanti hanno sintomi di avvelenamento da piombo. La porta seguente, su una lavagna sono scritti "cane" e "gatto", qui c'è la scuola. Poi una scala conduce al centro femminile, dove si insegna igiene. Nonostante questi servizi, gli abitanti ripetono che quella non è casa loro.
"Non è cambiato niente," dice Skender Gusani, leader dei campi di Osterode, Cesmin Lug e Leposavic. "Quando la gente si è spostata a Osterode, ci furono promesse tante cose e niente è cambiato. Ci hanno promesso acqua corrente ed elettricità per tutte le 24 ore, e riscaldamento. Qui l'inquinamento è migliore, ma i bambini sono ammalati per le condizioni di vita."
Hasan Kelmendi, manager del campo per la Norwegian Church Aid conferma che la pressione dell'acqua è inconsistente e lo stesso vale per l'elettricità, ma questa è la situazione che vige in tutta Mitrovica. "Posso dire che la situazione a Osterode è migliore degli altri campi," aggiunge indicando i servizi igienici e la lavanderia.
Ad ogni famiglia è assegnato una piccola stufa elettrica, che serve a poco quando manca la corrente, dice Gusani, che poi descrive le situazioni in cui si accende un piccolo fuoco sul pavimento per scaldarsi.
Sono stanchi di vagare tra campi, regolamenti e cancelli. "Viviamo come animali," dice Gusani. "La sorveglianza controlla ogni nostra cosa. E' come vivere in un campo di concentramento."
Neville Fouche, coordinatore della Roma Task Force dell'UNMIK, dice che i cancelli sono più per la sicurezza che per ostruzione. Permettono all'agenzia di controllare che entra nel campo. Poi Fouche ritiene che bruciare le batterie, da cui estrarre il piombo, peggiora il problema dell'inquinamento dei campi.
Poi sottolinea che il nuovo campo di Osterode, che riunisce tre campi in uno, è una soluzione temporanea. "Non abbiamo intenzione di renderlo permanente," dice. "Questo è soltanto un centro di transito per condizioni mediche". Aggiunge che la meta ultima è il ritorno degli abitanti alle loro case.
IN MEZZO DA QUALCHE PARTE
Il suono gutturale delle sillabe tedesche collide con il tono lirico del romanes mentre Feruz Jahirovic apre la porta e saluta la sua famiglia, una delle nuove nel campo. A differenza di Jahirovic, che ha passato otto anni nei campi, nove membri della sua famiglia hanno vissuto gli ultimi 15 anni a Munster, Germania. Si dividono due stanze in un edificio di mattoni rossi.
Quella di Jahirovic è una del crescente numero di famiglie che hanno perso lo status di rifugiati all'estero e sono state forzate al ritorno. Il Consiglio d'Europa stima che oltre 1.000 Rom siano stati rimandati in Kosovo. Centomila, la maggior parte dalla Germania, sono a rischio di ritorno forzato. E' difficile per quei bambini interagire con i loro coetanei, dato che questi nuovi arrivi sono cresciuti in Germania e parlano tedesco. Arrivati ad Osterode un anno e mezzo fa, anche loro hanno lasciato una casa.
"Avevano una vita come altri ragazzi in Europa," dice Jahirovic, scuotendo la testa e guardando i nipoti, che parlano l'inglese meglio del serbo. "Ora che faranno? Cosa faremo?"
Il ritorno dei rifugiati ha aumentato la pressione sulle autorità internazionali per trovare un posto dove i Rom possano vivere. A Mitrovica, si stanno costruendo nuove case, al posto delle rovine.
Sono per quanti una volta vivevano nel quartiere rom.
Dal suo punto di vista Jahirovic guarda le nuove case che sorgeranno accanto al fiume Ibar a Mitrovica sud. Si ricorda di quando suo fratello aveva stanze spaziose, prima che una delle più ricche e vasta comunità rom fosse distrutta.
99 famiglie hanno fatto richiesta per 48 appartamenti, ma Jahirovic non è nella lista. Ha nove bambini, più di ogni altro ad Osterode. Il 70% degli occupanti di Osterode proviene dal quartiere rom dall'altra parte della città. Jahirovic invece viveva in un villaggio vicino che è stato dato alle fiamme [...]
"Dove andremo, a vivere per strada?" chiede riferendosi al 30% degli abitanti del campo che non sono originari del quartiere che una volta aveva 8.000 abitanti. Il Consiglio dei Rifugiati Danese si èimpegnato a ricostruire le case di quanti siano in possesso della documentazione adeguata che certifichi che vivevano nel quartiere di Mitrovica sud. Norwegian Church Aid intende costruire le case anche per quanti non hanno documentazione, ma questa iniziativa appare più incerta.
"In quanto minoranza, non mi importa chi comanderà in Kosovo. Mi interessano la libertà di lavorare, la sicurezza ed i miei bambini," dice Jahirovic guardando la recinzione del campo.
IL PROSPETTO DEL RITORNO
Sino all'anno scorso, l'unica evidenza di quel quartiere erano resti di pareti di mattoni e muri sbriciolati. [...] La ricostruzione della Fabricka Mahala - mahala è un termine turco per "quartiere" che ha lo stesso significato tanto in serbo che albanese - è il più grande progetto di ritorno dei Rom mai intrapreso nei Balcani, dice Fouche.
Per quanti faranno ritorno alla mahala, la sua posizione a Mitrovica sud significa un cambio di servizi e linguaggi. Quanti vivono nei campi ricevono i servizi sociali dal governo serbo ed anche i bambini frequentano le scuole serbe. Quanti faranno ritorno alla mahala dovranno andare nelle scuole albanesi e non riceveranno più aiuti dalla Serbia. Con queste incertezze alcuni Rom, come il loro leader Gusani, rifiutano di tornare nel loro vecchio quartiere.
"Mio figlio sarà in grado di continuare la scuola?" chiede Gusani esprimendo una preoccupazione di molti nei campi. "Avrò libertà di movimento da casa mia?" aggiunge, riflettendo sul fatto che la sicurezza dei residenti nelle enclavi serbe come Mitrovica nord non è garantita in territorio albanese.
Come Gusani, molti Rom hanno timore di ritornare nel quartiere da cui sono stati espulsi. Dice Fouche che la forza internazionale di pace controllerà ogni due ore l'area, ma Gusani nega che nessun gliel'abbia mai comunicato.
"Nessuno garantisce che i miei figli avranno un futuro sicuro," spiega così perché ha scelto di non fare ritorno alla mahala. Attraversa il confine sud in caso di riunioni, solo sotto scorta dell'UNMIK. Se deve andarci da solo, dice di provenire dal quartiere Askali. "Se torneranno Rom ed Askali, ci saranno violenze," dice risolutamente.
LE PAURE
Tina Gidzic, una donna rom di 20 anni, prova crampi allo stomaco quando guida verso il suo ex-villaggio, Dobrevo. La città ora è un cumulo di macerie osservabile dall'autostrada Pristina–Mitrovica. Lei nn ha speranze di ritorno. La sua famiglia continua a vivere in Kosovo, ma la casa ora è quella con suo marito a Niš la città serba più vicino al protettorato.
Memorie di guerra: la sua casa, come molte altre, fu distrutta nel 1999 quando aveva 13 anni e non è stata ricostruita. Gidzic ricorda di essere cresciuta col suono delle bombe e sua madre che le diceva di non uscire da casa. Suo fratello più giovane è nato a Preoce, una piccola enclave serba a 10 km. da Pristina dove sono fuggiti i suoi genitori e dove vivono tuttora.
"Sto diventando nervosa," dice, non riferendosi soltanto al suo villaggio, ma anche all'incerta situazione dello status del Kosovo. "Qui i Rom sono musulmani come gli Albanesi, ma non vogliamo entrare in urto con i Serbi," che sono ortodossi, ci spiega. "Viviamo tutto il tempo con i Serbi, ma loro dicono che stiamo aiutando gli Albanesi."
Anche se non sempre sono un bersaglio, ma si trovano sulla linea di fuoco, pensa Gidzic. "Quando gli Albanesi attaccano i Serbi, non sanno se una casa è serba o rom, così bruciano l'intero villaggio. E' così che la violenza ci colpisce."
Tina scende dalla macchina e rinchiude il cancello della nuova casa della sua famiglia, una struttura che apparteneva a suo nonno. Raggiunge sua madre, riscaldandosi in una stanza dove funziona la stufa.
Sua madre, Miradija, piange ancora quando vede la foto della vecchia casa di Dobrevo. [...] Mentre la guarda dice una delle poche parole inglesi che conosce: "home".
TENTATIVI DI MOBILITAZIONE
I Rom non sono tutti silenti sull'argomento indipendenza, neanche Gidzic lo è. "Dovrebbe essere così," dice accompagnando la seconda tazza di caffé turco in una stanza che è cucina, camera da letto e salotto. "I Serbi dovrebbero tornare in Serbia, gli Albanesi in Albania e così i Rom potrebbero stare in Kosovo."
Dopo otto anni di identità fluttuanti e in una terra che potrebbe mai essere la loro, alcuni Rom stanno reagendo. Gli attivisti criticano apertamente la missione ONU. Recentemente hanno prodotto un documento dove indicano i loro desideri rispetto al Kosovo indipendente. Tra le loro richieste la partecipazione alle decisioni sullo status del Kosovo, come pure la strategia di ritorno per i rifugiati. "Se non siamo chiari su cosa vogliono le minoranze in Kosovo, ci porteremo dietro un monte di problemi," dice Bashkim Ibishi, uno degli autori del documento.
Ibishi è Rom, ma è anche un ufficiale ONU per gli affari delle minoranze in Kosovo. "Non ci sono programmi di assistenza, perché nessuno vuole avere a che fare con noi," dice.
A quindici km. di distanza, Saffet Ramic non ha intenzione di rinunciare al suo cacciavite. Continua a spostare le sue targhe e parla di una discussione avuta con un abitante di Kosovo Polje. Stanno considerando di iniziare un affare importando scarpe dall'Albania e rivendendole a buon mercato nel Kosovo.
"E' un piano," dice salendo sul furgone. Poi si ferma, gli appare un sorriso sul volto e conclude "Se esisteremo ancora."
Jessica Meyers is a student at the University of California-Berkeley Graduate School of Journalism.

Maurizio Pagani*, 26 gennaio 2007
In 500 mila trovarono la morte nelle camere a gas naziste, anche se è difficile ancora oggi stabilire con certezza la proporzione della persecuzione. In Italia, la legge che istituisce la Giornata della Memoria, non estende il riconoscimento alla loro tragedia
Durante la seconda guerra mondiale oltre 500.000 zingari trovarono la morte nei lager nazisti di tutta Europa. Si trattò di una persecuzione "razziale", assimilabile a quella ebraica, fondata su una presunta "asocialità biologica" degli zingari, la cui origine indoeuropea, cioè ariana, era stata irrimediabilmente compromessa dalle contaminazioni con i popoli "slavi" e dalla presenza del gene del wandertrieb, l'istinto al nomadismo. La persecuzione degli zingari fu però anche la conseguenza più o meno diretta dei pregiudizi che la società europea aveva maturato nei loro confronti, ricollegandosi a una storia secolare di incessanti discriminazioni.
Nella lingua zingara, il romanès, vi è una parola per indicare la propria shoà: porrajmos, che significa letteralmente distruzione, divoramento. La scarsità delle fonti storiche disponibili fino ad oggi in Italia ha segnato il limite più evidente per documentare le responsabilità del fascismo circa le deportazioni e le stragi che subirono le comunità rom e sinte. Già i Rom stranieri presenti sul territorio italiano, insieme a saltimbanchi e girovaghi, vennero a trovarsi nel mirino della polizia fascista dal 1926, respinti oltre frontiera benchè provvisti di regolare passaporto. Ma saranno gli articoli degli scienziati Renato Semizzi e Guido Landra, consulenti di Mussolini ed estensori delle Leggi Razziali, a segnare tra il 1938 e il 1940 una svolta significativa del regime. L'ampia discrezionalità nell'applicazione estensiva di alcune norme anti - ebraiche e il ricorso a disposizioni prefettizie in materia d'ordine pubblico, consentirono infatti l'invio al confino e l'internamento nei campi di prigionia dei rom sul territorio nazionale o la deportazione verso i lager nazisti, segnando una continuità di sostanza con quanto di più cruento ed efferato avveniva nei territori dell'Europa Orientale. Nel 1938 ebbero dunque inizio nelle regioni del Nord Est rastrellamenti e deportazioni in massa di famiglie rom verso il meridione e le isole. In seguito alle prime disposizioni d'internamento inviate dal Capo della Polizia di allora Arturo Bocchini ai Prefetti del Regno e al Questore di Roma con Circolare dell'11 settembre 1940, zingari stranieri e italiani furono arrestati e trasferiti nei campi provinciali allestiti dal Ministero dell'Interno a Bolzano, Berra, Boiano, Agnone, Tossicìa, Ferramonti, Vinchiaturo e nelle isole, tra cui la Sardegna, la Sicilia e le Tremiti.
Tranne che in studi più recenti, "la memoria custodita nelle comunità Rom" è stata di fatto ignorata, tralasciando di raccogliere i racconti dei perseguitati e di incrociarli con i dati riscontrabili negli archivi statali, comunali, delle questure e dei giornali dell'epoca, rimuovendo e tacendo un vuoto storico carico di una forte responsabilità sociale. I piani di sterminio del popolo Rom vennero attuati non solo nei territori annessi dal dominio nazista ma anche dai governi collaborazionisti, in particolare in Romania e Jugoslavia, che furono, con la Polonia, tra i principali teatri di questa efferata persecuzione. Non solo i limiti della precisione statistica e lo stato di guerra generalizzato, ma la stessa struttura sociale dei gruppi rom e il loro prudente "mimetismo", che rendeva parziale il censimento anagrafico dei nuclei familiari, la forte dispersione territoriale, le sommarie registrazioni degli internati e la distruzione dei documenti rendono arduo il compito di dire quanti furono gli zingari sterminati. Si sa però che interi gruppi sparirono da zone di antico insediamento, come l'Olanda, insieme alla quasi totalità della generazione degli anziani, depositari del sapere e delle tradizioni. In Italia, la legge dello Stato che istituisce la Giornata della Memoria, non estende il riconoscimento alla tragedia subita dagli zingari.
Quella "Rom" è una delle grandi questioni morali che riemerge nell'Europa di oggi. Una diaspora di popolazioni lacerate dalle nuove povertà e dai processi di modernizzazione, dalla perdita di protezioni sociali nelle proprie comunità di antico insediamento che danno impulso a nuove immigrazioni. L'Italia accoglie una minima parte dei Rom che emigrano, con un ritardo culturale grave a cui si associano politiche pubbliche logore o discriminanti. La politica dei campi nomadi, ad esempio, è una mera invenzione amministrativa, "tutta" italiana, che condanna le comunità romanì all'emarginazione e alla ghettizzazione per il ripetersi di politiche di esclusione e assimilazione, collocandole sostanzialmente al di fuori della società, dei legami sociali stabiliti, dei rapporti familiari e di vicinato.
In Italia, paese il cui tasso di "fastidio" verso i Rom non è certo minore alla media europea, i casi di violazione dei diritti privati ai danni dei Rom compiuti dalle Istituzioni per mano dei comuni o delle prefetture rischiano, come nel recente caso del comune di Opera alle porte di Milano, di "innescare" un'analoga violenza immotivata e razzista di una parte della popolazione o delle forze politiche che ne alimentano ad arte il malcontento.
L'immagine sociale che ne emerge diviene così, del tutto impropriamente, quella centrata sulla devianza, il disturbo e la pericolosità sociale che vanno sanzionati e disciplinati con rigore. Dichiarare, come è stato fatto e scritto dalle Istituzioni milanesi e dalla Casa della Carità di Don Virginio Colmegna che le comunità rom dovranno da qui in avanti sottoscrivere un "patto di legalità e socialità", unici tra i cittadini di questo Paese a cui viene richiesto, in cambio di interventi pubblici di "solidarietà", è come affermare implicitamente che i Rom sarebbero "portatori di illegalità e asocialità". Come nelle più buie epoche del passato. Le politiche "emergenziali" hanno dunque il fiato corto e scansano i più scomodi nodi strutturali, quali quello della condizione abitativa metropolitana, producendo nell'immediato solo nuovi ghetti sociali. Il rapporto tra la nostra società e quella rom andrebbe viceversa riportato nell'ambito di una dialettica sociale che riconosca e rispetti i valori culturali e umani delle specifiche identità. Senza riconoscimento e reale negoziazione non vi può essere una condizione di diritto e di eguaglianza ma, solo, la tentazione di percorrere scorciatoie "differenziali" che modificano il quadro giuridico e il "trattamento istituzionale" a cui si sottopone la parte più debole dei nostri concittadini.
*Vicepresidente Opera Nomadi Milano

By Zoran Radosavljevic

POSTOJNA, Slovenia (Reuters) - Elka Strojan e la sua famiglia Rom estesa di 30 elementi, forzati a lasciare la loro casa per andare in un ex caserma, rimarcano la precaria esistenza nei Balcani della più vasta minoranza d'Europa
"Qui stiamo davvero male. Non è casa nostra, è per i rifugiati e non lo siamo. Siamo cittadini sloveni con tutti i documenti" ci dice la signora, 55 anni, in uno stentato sloveno, seduta su un vecchio letto circondata da due cani e da una dozzina di nipoti.
Agli Strojan, inclusi i quattro figli di Elka e le loro famiglie, alla fine di ottobre il governo chiese di lasciare le loro case vicino ad Ambrus nella Slovenia centrale, dopo che i villici arrabbiati minacciarono di espellerli di forza.
Il Consiglio d'Europa ha criticato il neo-membro Slovenia per quello che era successo, ma gli abitanti del villaggio dicono di averne abbastanza dei Rom, dei loro furti e delle liti.
"Circa 600 viviamo vicino a loro. Volevamo bruciare e distruggere tutto ma siamo arrivati troppo tardi, la polizia era già schierata," dice il pensionato Joze Lindic.
"Non abbiamo niente, ma i problemi ci sono da 20 anni e non ne possiamo più. Che lo stato o l'Unione Europea se ne facciano carico. Non li vogliamo qui, mai più," ci dice stappando una birra al caffé.
Il governo ha promesso di provvedere ad un'alternativa alloggiativa permanente per gli Strojan, ma l'annuncio ha immediatamente sollevato le proteste dei residenti nelle potenziali nuove località.
IL RAPPORTO DI AMNESTY
Un recente rapporto di Amnesty International sui Rom in Slovenia, Croazia e Bosnia riporta che vivono in povertà estrema e che i loro bambini affrontano regolarmente discriminazioni a scuola.
"Le barriere che i bambini Rom affrontano nell'accesso alla scuola, li priva della possibilità di uscire dalla marginalizzazione".
Soltanto due della dozzina di figli degli Strojan andavano a scuola mentre vivevano ad Ambrus.
L'accesso alla scuola è persino peggiore per i Rom di Serbia, stimati in 500.000.
Secondo il censimento, il 34,8% dei Rom di Serbia sono analfabeti e soltanto il 20% hanno completato la scuola dell'obbligo. Quanti iscrivono i bambini a scuola, spesso lo fanno per accedere all'assistenza sociale.
"La società globalmente esprime nessun interesse per i loro problemi e bisogni," dice un rapporto dell'UNICEF, l'agenzia ONU per l'infanzia.
"Questo potrebbe essere causato da indifferenza generale, intolleranza e stereotipi dominanti sui Rom, dovuto alla poca conoscenza della storia, della cultura e tradizione dei Rom,"
SEGREGAZIONE
In Croazia, che spera di raggiungere l'EU nel 2010, i residenti della prospera regione di Medjimurje, che ha la più grande comunità Rom, protestarono nel 2002 contro le classi miste di Rom e Croati.
I Croati dicevano che i genitori Rom erano "spesso alcolizzati e i loro figli inclini al furto e a litigare", spesso con scarsa conoscenza della lingua croata.
I Rom hanno risposto compilando un atto d'accusa contro la segregazione alla Corte Europea per i Diritti Umani. Il caso è tuttora in discussione.
La situazione è di poco differente in Bulgaria e Romania, entrambe entreranno nella EU il prossimo gennaio.
I dati governativi calcolano la popolazione Rom in Romania in circa 535.000, ma una stima dei Gruppi sui Diritti delle Minoranze li pone sopra i 2.500.000, che ne farebbe la più grande popolazione Rom in Europa.
Le organizzazioni dei diritti dei Rom accusano le autorità di discriminazione continuata, reclamo sostenuto da molti osservatori occidentali.
La Bulgaria è anche stata criticata dalla Commissione Europea per fare troppo poco per integrare i Rom, che vivono ai margini della società, spesso in bidonvilles che mancano di acqua corrente ed elettricità.
Scolarizzazione adeguata e impieghi permanenti sono rari.
Una recente ricerca della commissione bulgara anti-discriminazione mostra come le tensioni etniche sono aumentate come risultato della percezione dei Rom della discriminazione.
"Le basi per la percezione della discriminazione si trovano nell'ampio dislivello nelle condizioni di vita, come pure nella sfiducia dimostrata da altri gruppi etnici contro i Rom," recita l'indagine.
Mirko Strojan, uno dei quattro uomini della famiglia di Rom sloveni, dice che la famiglia intende passare alle vie legali..
"Una cosa simile, che i nostri vicini vogliano farsi giustizia per conto loro oltrepassando la legge, non è mai successa. Intendiamo citare in giudizio il villaggio, fargliela pagare per i danni, la vergogna e la paura," ci dice.
(Additional reporting by Ljilja Cvekic in Belgrade, Tsvetelia Ilieva in Sofia and Marius Zaharia and Justyna Pawlak in Bucharest)
(c) Reuters 2006. All rights reserved. Republication or redistribution of Reuters content, including by caching, framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Reuters. Reuters and the Reuters sphere logo are registered trademarks and trademarks of the Reuters group of companies around the world.
This article: http://news. scotsman. com/latest. cfm?id=174844200 6
Last updated: 25-Nov-06 01:33 GMT
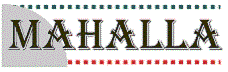



 Permalink
Permalink Oppure
Oppure >>
>> Stampa
Stampa





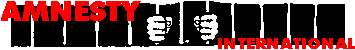








 Feed RSS 0.91
Feed RSS 0.91 Feed Atom 0.3
Feed Atom 0.3
