|
Di seguito gli articoli e le fotografie pubblicati nella giornata richiesta.
Articoli del 18/04/2009
Anche se alcune affermazioni possono non piacere (o sono di difficile
condivisione), l'articolo ha diversi spunti interessanti, nel tratteggiare
quella che può essere definita la "memoria nomade" collettiva. Che è anche il
limite dello scritto, date che ogni popolazione ha avuto un passato nomade e col
tempo si è evoluta con differenze notevoli.
Il portale dei giovani della pace giovedì 16 aprile 2009
Renato Rosso ama comunicare e condividere le sue esperienze, e, partendo
da esse, riflettere sul nostro quotidiano. Questa volta lo fa con "storie
parallele" di popoli zingari, quelli che abitano Paesi lontani, terre di antica
origine, e quelli insediati in Europa, in Italia.
Renato Rosso: 36 anni di missione itinerante (Bangladesh, India, Filippine,
Brasile, Italia…) al servizio di comunità diverse dell’universo zingaro. Un
inconsueto tipo di presenza, non sempre stabile, ma che ha costruito, con tempo
e fatica, una Chiesa in realtà che senza di lui forse non sarebbero mai state
raggiunte. Presenza di crescita umana e spirituale in comunità non cristiane;
soprattutto animando scuole - sovente itineranti su barche, o nei pascoli… -
disegnate sul modello di vita degli alunni. Suscitando energie, formando persone
che finora hanno assicurato non solo continuità ma anche crescita delle
iniziative, grazie alla loro testimonianza.

Ha senso guardare in parallelo le civiltà nomadi che tu incontri in Asia e
quelle dei Balcani, dell’Italia e di altri Paesi?
Io parlerei di nomadi nel mondo. Inclusi i nostri, qui in Italia, tutti
partono dall’India nord occidentale, 700-800 anni fa. In Grecia li troviamo già
nel 1300 e nel 1400-1420 in Italia; pochi anni dopo in Francia, in Spagna e in
breve in tutta Europa.
Ancora prima, nel 1700 a.c., nasceva la cultura nomade beduina in Arabia,
allargandosi poi nel Nord Africa e fino all’Afghanistan, all’India.
La sedentarizzazione inizia più o meno 12.000 anni fa, ma nell’Asia poco tempo
fa. Alcune frange sono rimaste nomadi, e sono quelle che noi incontriamo oggi.
Personalmente, ho elencato 440 di questi gruppi, nomadi o seminomadi, nel
subcontinente indiano.
Esistono similitudini tra zingari europei e zingari del subcontinente indiano?
Sono molto simili. È il tipo di vita che crea il loro modo di essere: il vivere
sotto il cielo, il contatto con la natura. Cambiano il modo di vestire, le
lingue. Però il modo di pensare, di fare politica all’interno del gruppo, di
relazionarsi con gli altri sostanzialmente è simile.
Per esempio il gruppo - una quindicina di famiglie - si difende con un capo,
eletto e che ha l’ultima parola; hanno un tribunale loro, con avvocati e giudici
eletti. Non fanno riferimento alle autorità locali. È interessante il fatto che
nel loro vivere la politica presentano una democrazia diversa, non riferita ad
un’ideologia. Il segreto è considerare ogni membro del gruppo come uno della mia
famiglia.

Di questa cultura, conosciuta solo attraverso pregiudizi, quali sono secondo
te i valori importanti?
Il valore centrale è la famiglia, la loro ricchezza sono i figli. Non hanno
altro. In Europa come in Bangladesh, quando uno ha sbagliato viene giudicato ed
eventualmente punito, sempre però tenendo conto che potrebbe essere mio figlio,
mio fratello. Ci si relaziona con una persona e la sua storia, non con un
numero. Pensa quale rivoluzione!
Ci sono altri aspetti interessanti, come la possibilità di fare scelte meno
dipendenti da norme formali. Ovviamente l’istinto è anche un limite: promuovere
la scuola per loro è proprio lavorare su questo. Anche la religiosità è un
valore cui danno grande importanza. Con la nostra presenza cerchiamo proprio di
arricchire tutti questi elementi.
Che tipo di rapporto vive il nomade con la società che lo circonda?
Rimangono minoranze. Uno zingaro in Italia è visibilmente diverso da chi vive in
una casa.
Anche se, in tutto il mondo, la casa non è la roulotte, la carovana o la tenda:
la casa è l’accampamento. Dove tutti vivono e i bambini sono educati al ritmo
del gruppo, dal gruppo intero. La famiglia nucleare esiste, però è nel gruppo
che si decide, per esempio, di mandare i bambini a scuola; papà e mamma
potrebbero arrivarci un po’ prima, ma dovranno aspettare il gruppo. È sempre il
gruppo che deve essere motivato e non un singolo.
Sia qui che in India poi - benché in India la gente comune dei villaggi possa
essere più povera degli zingari - lo zingaro è una persona di cui si ha paura.
Perché è nomade, e non sai da dove viene e dove va.

Solo timore, non fascino?
Anche, le due cose si mescolano. Per esempio, gli zingari la sera si riuniscono
e cantano, danzano; questo crea un certo fascino, ma il timore e il disprezzo
restano.
Molte volte anche da parte di chi, zingaro, si è sedentarizzato. Uno dei motivi
è l’assenza del concetto di proprietà privata, che rende liberi nel rubare. Cosa
che in Asia è rarissima: c’è poco da rubare, i ricchi sono pochi e si difendono
molto bene; e normalmente i nomadi lavorano tutti. Qui in Europa la situazione è
diversa. In passato procurarsi il sostentamento non era difficile, incluso
razziare qualche gallina… Poi la società è cambiata, le esigenze anche e le
piccole delinquenze sono diventate organizzate; oggi abbiamo anche in mezzo a
loro una criminalità pesante.
Non c’è più uno spazio economico per un’attività tradizionale. Occorre avere
altre capacità…
Certo. È già accaduto in Asia, ma in Europa è stato appunto diverso. Nel
polverone riguardo al mondo zingaro in Italia, parte del problema è però
aggravato da una corruzione che ci riguarda. Ci sono avvocati che lucrano su di
loro. Se qualche anno fa con 5 milioni di lire si faceva un processo, oggi si
chiedono 100 o 150mila euro. In qualche modo si è detto loro: non è importante
essere onesti o disonesti, rubare o non rubare, ma avere tanti soldi per
risolvere i problemi. Se rubi poco, rimani in prigione.
Il rischio è che il resto della società pensi che gli zingari sono i nemici, e
che loro pensino che il resto della società è il nemico. È un cane che si morde
la coda. Gli zingari arrivano da noi con una certa ingenuità, con una
fisarmonica, un bicchiere di plastica, girando sotto le finestre, suonando. Però
poi lentamente sono assorbiti dalla criminalità organizzata, per la quale più
sono meglio è. A volte sento dire: "Io non voglio, ma cosa faccio? Mi
obbligano".
Moltissimi Sinti e Rom per fortuna lavorano: da trent’anni a questa parte sono
entrati nei Luna Park e nei circhi. Un lavoro pesante ma dignitoso. Ultimamente
hanno anche altre attività, come paninoteche ambulanti, bar… una Sinta era
entrata giovane al mattatoio di Torino: ora avrà trent’anni ed è capo reparto,
per la sua intelligenza, per la sua onestà, per la sua capacità.

Chi lavora si sedentarizza?
Vivono nel campo, nella roulotte con gli altri, ovviamente una vita sedentaria
perché chi ha un lavoro fisso non può spostarsi. Intanto i loro parenti e gli
altri svolgono altre attività, qualcuno non ne fa nessuna… c’è di tutto.
Uno dei problemi, oggi, é l’arrivo di nuovi gruppi dall’est. Secondo me l’unica
via d’uscita è che anche noi italiani decidiamo di diventare una nazione più
onesta. Una nazione davvero fondata sul lavoro, dove chi non lavora non mangia.
Dove chiunque, se ruba o delinque, è punito, in proporzione alla gravità del
fatto, senza scappatoie.
Tanti di noi sono consapevoli di vivere in una società dove esiste una cultura
mafiosa, ma scelgono la legalità.
Penso sia più alta nel mondo degli zingari la parte delle persone che dicono:
comincio io. Solo in Piemonte, sono alcune centinaia, negli ultimi due anni,
quelli che sono entrati nel mondo del lavoro, dopo le migliaia già assorbite dal
mondo dei luna park. Persone che si sono rifiutate di entrare nella criminalità.
Ricordo un papà con due figli a Milano, coinvolto nella criminalità, che ha
fatto di tutto perché i figli non facessero la sua stessa vita. Ha cercato di
dare un lavoro a entrambi. Con un figlio è riuscito, con il secondo no. A
Torino, due anni fa, c’è stata una catechesi all’interno dell’accampamento,
tenuta da una catechista Sinta: questo papà tutte le settimane veniva con un
figlio. Voleva salvarne almeno uno e ha cercato di offrirgli anche una fede che
lo potesse aiutare, dei valori. Persone così non sono una minoranza.

Che prospettive vedi per lo stile di vita nomade?
Non ho mai chiesto a uno zingaro nomade di sedentarizzarsi, né a uno che vuole
sedentarizzarsi di continuare ad essere nomade. Penso che il compito di un
operatore responsabile sia stare accanto a questi fratelli. Noi da tempo
forniamo la scuola come elemento aggiuntivo: saranno poi loro a decidere come
utilizzarlo. Ci sono bambini che quattordici anni fa hanno iniziato in
Bangladesh, in India con le nostre scuole mobili, nell’accampamento, sotto le
tende, sotto gli alberi, in maniera del tutto informale. Dopo un paio d’anni
sono andati da parenti, per continuare alla scuola pubblica. Sono diventati
insegnanti e adesso sono tornati nell’accampamento e fanno scuola agli altri
bambini, continuando ad essere nomadi.
Arricchiscono la comunità…
Certo, una grande ricchezza. Altri invece sono andati a scuola e non sono
tornati alla vita nomade. La scelta è loro. Noi offriamo mezzi di sviluppo per
poter fare qualche passo in più, se lo desiderano. Io penso che abbia un senso
la vita nomade, come ha un senso la vita sedentaria, salvo che si voglia fare
violenza su questa umanità e creare una cultura unica.
Cent’anni fa Francesco Predari, autore del primo testo italiano interamente
dedicato al tema, diceva: "Se qualcheduno volesse conoscere un poco la cultura
zingara, cerchi di farlo in fretta, perché entro pochi anni spariranno e fra
cento anni non ci sarà nemmeno più il ricordo di questo gruppo etnico". Cento
anni sono trascorsi, e gli zingari sono molti più di allora: in Italia si parla
di 80.000, oltre all’ultima ondata di rumeni. A Torino soltanto in questi ultimi
due anni ne sono arrivati 2.500.
Cos’è la speranza per il futuro di uno zingaro?
Il mondo zingaro non ha prospettive di lungo periodo, pensa a sistemare i suoi
figli oggi, adesso. Non c’è una percezione vera e propria del senso della
storia. È una scelta di vita che porta con sè una percezione completamente
diversa di molte cose.
intervista di Mauro Palombo
foto di Toni Gortz
da
Nuovo Progetto dicembre 2008
Vedi la scheda "Bangladesh, scuole itineranti" dedicata alla collaborazione
tra il Sermig e don Renato Rosso.
Da
Roma_Daily_News
America.gov 7 Aprile 2009 I Rom in America di Carlos Aranaga Staff
Writer
Diversi, una comunità di milioni valuta la sua identità culturale
 John Nickels è un attivista rom di Wildwood, New Jersey,
che dice ciò che pensa sui pregiudizi contro gli Americani di origine rom
John Nickels è un attivista rom di Wildwood, New Jersey,
che dice ciò che pensa sui pregiudizi contro gli Americani di origine rom
Washington - Nella Giornata Internazionale dei Rom, l'attenzione sarà
sull'Europa, dove il popolo rom è sopravvissuto a secoli di marginalizzazione e
persecuzione. Anche oggi i Rom europei chiedono parità sociale ed opportunità
economiche. Meno conosciuti sono i Rom USA, che l'Ufficio del Censimento
conta a poco più di un milione, dispersi negli USA, con gruppi presenti nel
Texas, in California e nel Midwest.
Il popolo rom traccia le sue origini nell'Europa orientale e centrale, ma è
stereotipato negativamente negli Stati Uniti ed in Europa, sempre più spesso dai
media popolari come "Zingari", con presunti comportamenti antisociali. I
preconcetti hanno portato al pregiudizio e alla profilatura etnica, incluso
leggi locali discriminatorie.
La Giornata Internazionale dei Rom celebra la cultura romanì ed aumenta la
consapevolezza delle tematiche affrontate dal popolo romanì. L'8 aprile è stato
scelto come ricorrenza annuale dal quarto Congresso Romani Mondiale, tenutosi in
Polonia nel 1990. Anche gli Stati Uniti in questo giorno chiamano al rispetto
dei diritti umani dei Rom.
Il professore Ian Hancock dell'Università del Texas ad Austin, preminente
studioso Rom americano, dice che nel nord America ci sono stati Rom dall'epoca
coloniale, quando piccoli numeri [di loro] vennero portati dalla Bretagna per
lavorare nelle piantagioni della Virginia, Barbados e Giamaica. Un numero più
grande di immigrati rom cominciò ad arrivare in America alla fine del XIX
secolo, spinti dalle guerre e dal tumulto sociale in Europa.
L'emigrazione continua a tutt'oggi, dice Hancock, lui stesso immigrato di
origine Romanichals, I Romanichals sono il ramo romanì che si trova nel Regno Unito.
Romanì è anche un termine usato per descrivere i dialetti usati da rami del
popolo rom. Il linguaggio è fortemente influenzato dalle lingue locali, cosa che
può rendere difficili per i Rom di differenti regioni comunicare tra di loro.
Per i Rom tradizionalisti, dice Hancock, preservare la propria distinta
identità culturale è una preoccupazione preminente, anche se forti correnti di
assimilazione spostano i giovani verso la più vasta corrente culturale, come per
altre minoranze etniche ed immigrati.
"C'è un conflitto di cultura, una paura di perdere la propria -Romani-tà- e di
cambiare, che non è bene," dice Hancock.
Nathan Mick è un Americano di discendenza rom, che ha lavorato a Capitol Hill,
ha rappresentato gli USA in sedute diplomatiche, ed ora è un funzionario di
sviluppo economico a Garrard County, Kentucky. Mick parla degli elementi comuni
della cultura rom condivisi dai Rom americani.
"C'è un senso di comunità nella cultura rom che ci spinge a stare assieme
vicini, all'interno di rapporti di famiglia strettamente tessuti, per cui non
c'è molta interazione tra le differenti comunità rom, che isolano gli
stranieri," dice Mick.
"Crescendo, non ero cosciente del tutto delle mie origini," dice Mick. "Mio
padre non è Rom, mia madre Romanichal. Sono cresciuto nel Nebraska e giravo con
loro d'estate. Solo nel periodo della scuola superiore ho imparato la
distinzione. Poi ho saputo dell'Europa, soprattutto l'Olocausto."
Durante la II guerra mondiale oltre 700.000 Rom perirono nel genocidio nazista.
Un gruppo USA attivamente impegnato nel cambiare le vite dei Rom è The Voice of
Roma, a Sebastopoli, California, gruppo non-profit con un collegamento speciale
ai Rom che vivono come persone disperse in Kosovo. The Voice of Roma ha un
ufficio in Kosovo per implementare lo sviluppo economico, progetti umanitari ed
educativi. Negli Stati Uniti, il gruppo presenta arti e tradizioni culturali
romanì in una maniera che contrasta tanto gli stereotipi romantici che quelli
negativi.
Petra Gelbart, nata nell'odierna Repubblica Ceca, etnomusicologa ad Harvard e
volontaria presso Voice of Roma, che si focalizza sulle questioni femminili, ha
radici nei gruppi rom tedeschi, slovacchi, e ceco-moravi.
"Intendiamo aiutarli ad ottenere più voce e intervento riguardo l'attività
economica, istruzione e condizioni migliori nella comunità," dice Gelbart.
Il progetto del gruppo "Fili che Ci Connettono" aiuta i Rom a creare tessuti per
renderli più autosufficienti.
The Voice of Roma organizza tutto l'anno eventi culturali. "Canto e suono la
fisarmonica," dice Gelbart, che si esibirà a maggio. Per la Giornata
Internazionale dei Rom 2009, sono in programma concerti, laboratori di danza,
discussioni e festival del cibo rom, nelle sedi di Los Angeles, San Francisco ed
Arcata, in California settentrionale.
Secondo Sani Rifati, presidente di Voice of Roma, l'impatto della loro azione
culturale è stato "incredibile".
"Uscire nelle scuole di ogni grado e nei college vale realmente la pena. Gli
stereotipi culturali che sono lì di fuori stanno davvero paralizzandoci. Tutto
ciò aiuta."
Fotografie del 18/04/2009
Nessuna fotografia trovata.
|
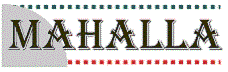








 Permalink
Permalink Oppure
Oppure >>
>> Stampa
Stampa John Nickels è un attivista rom di Wildwood, New Jersey,
che dice ciò che pensa sui pregiudizi contro gli Americani di origine rom
John Nickels è un attivista rom di Wildwood, New Jersey,
che dice ciò che pensa sui pregiudizi contro gli Americani di origine rom







 Feed RSS 0.91
Feed RSS 0.91 Feed Atom 0.3
Feed Atom 0.3
