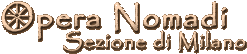
Associazione di Volontariato
Opera Nomadi Milano Onlus
Via De Pretis n. 13
0284891841 - 3393684212
www.operanomadimilano.org
operanomadimilano@tiscali.it
Dopo circa 6 mesi dall’avvio del nuovo anno scolastico, l’Assessore Moioli è in procinto di rinnovare l’incarico a termine alle 10 mediatrici Rom che da molti anni lavorano nella scuola primaria milanese.
Lo farà secondo il suo stile, quello cioè per lo più incurante del buon andamento dei servizi e del rispetto delle persone, che siano operatori, utenti o cittadini poco importa.
Lo farà cambiando le carte in tavola, o le "regole", secondo una tipica espressione ricorrente che però non trova quasi mai riscontro negli atti formali di questa Amministrazione.
Lo farà frammentando una storia, quella di un gruppo di donne rom, che non solo hanno saputo e potuto costruire la propria professionalità attorno all’esperienza avviata e sostenuta dalla sola Opera Nomadi in tutto il contesto milanese, ma approfittando di continue proposte di studio e aggiornamento portate avanti negli anni con l’attivo sostegno dell’Università e del CSA di Milano.
Lo farà infine, con la complicità e il "disinteresse" di quanti sono nel frattempo subentrati nella gestione dei campi comunali milanesi (associazioni, fondazioni e cooperative che si "spartiranno" il nuovo "scomodo" personale), accettando di rimanere troppo spesso in silenzio di fronte a quanto di negativo e sconcertante sta accadendo.
Il fallimento totale delle politiche sociali appare oggi infatti persino peggiore e devastante dello stato di abbandono in cui l’Amministrazione Albertini aveva lasciato questi insediamenti, privandoli di risorse, strumenti di dialogo e integrazione e peggiorandone quindi, inevitabilmente la condizione.
Ma che cosa è cambiato in questi due anni?
A partire dal famigerato "Patto di legalità e socialità", sostenuto oltre che dal Comune, dalla Prefettura, dalla Provincia di Milano e dalla Casa della Carità, la voragine che si è aperta attorno ai Rom appare inarrestabile, divorando e calpestando i diritti delle persone come se queste nemmeno esistessero.
Il prossimo passo, dopo un inizio d’estate caratterizzato dalla "caccia alle impronte" e da un censimento maldestro e ben poco veritiero, sarà quello della stesura definitiva di un Regolamento delle aree comunali che manderà definitivamente in soffitta la storia di un confronto spesso difficile e contrastato, quello tra i rom e la città, ma attorno a cui almeno si continuava a ragionare.
Regolamento o resa dei conti?
Riportiamo di seguito un intervento ripreso dal libro "I Rom e l’azione pubblica" (Teti editore – Milano – Novembre 2008) sulla storia e il significato della mediazione culturale in ambito scolastico e sanitario nella nostra città da parte di un gruppo di donne rom.
Introduzione
Sono trascorsi 15 anni da quando, a Milano, l’Opera Nomadi avviò il primo corso di formazione per mediatrici culturali scolastiche rivolto inizialmente a dieci giovani donne rom.
Da allora, altre romnià hanno seguito questa strada, lavorando fianco a fianco con gli insegnanti, nei consultori familiari, nelle amministrazioni locali e finanche nel Carcere di Bollate.
Alcune di loro hanno nel frattempo conseguito un diploma, frequentato corsi tenuti da docenti universitari, partecipato come relatori a master e convegni, imparando a gestire un lavoro complesso in condizioni di grande precarietà e di sostanziale isolamento sociale.
Certamente, il contesto culturale di quasi due decenni fa esprimeva un orizzonte di situazioni e relazioni critiche ma comunque aperte al cambiamento, dove anche i rom si illudevano di cimentarsi in un confronto nuovo alla ricerca di un proprio spazio di rappresentazione sociale e politica.
Oggi non più. L’isolamento spaziale dei campi nomadi, quelli che molti definiscono con qualche eccesso delle pattumiere sociali ma che segnano il confine simbolico e materiale di una separazione reale, unitamente al forte pregiudizio politico, fulcro di politiche amministrative discriminatorie ed inefficaci, hanno ristretto fin quasi ad annullare del tutto questa prospettiva.
Le cose cambiano? Sì, un po’, lentamente, faticosamente. Ma la realtà, guardata dal punto di vista dei Rom è sempre quella: il fastidio, la diffidenza, il disprezzo, l’apartheid.
Immobili, permanenti, pesantissimi.
La fase contemporanea è segnata da un’assenza di proposte e dal congelamento delle risorse pubbliche. Assistiamo invece un po’ attoniti all’inasprimento di norme ideologiche autoritarie e sanzionatorie (a Milano e Roma rappresentate dai "Patti di Legalità e socialità"), mitigate nei lori effetti più devastanti da un complice sostegno offerto da enti e fondazioni ecclesiastiche promotori di interventi assistenziali e caritatevoli. Non di diritti.
Quand’anche i più attenti critici fanno osservare che spessissimo gli investimenti pubblici non raggiungono le persone alle quali sarebbero indirizzati, se non in forme indirette e di servizi dei quali sono solo fruitori, si dimenticano di indicare attraverso quali processi alternativi i rom potrebbero appropriarsi di strumenti indispensabili per agire sul proprio destino.
Perché i problemi esistono e sono reali e si chiamano mancanza di istruzione, lavoro, riconoscimento e tutela della salute, scarsità o inadeguatezza di abitazioni e abbandonati a loro stessi e al tentativo contraddittorio e lacerante di tenere insieme, in un equilibrio instabile, valori e modelli tradizionali con quelli imposti dall’asimmetria economica e culturale della globalizzazione, non possono che aggravarsi.
Ogni cultura dà per scontato che il proprio modo di comunicare, i suoi valori, le rappresentazioni della realtà siano in un certo senso uniche o migliori e che gli altri, per esempio gli appartenenti alle minoranze, debbano adeguarsi anche senza condividerle.
E’ necessario invece aumentare le capacità di interazione delle comunità e consolidare la presenza di figure professionali, quali i mediatori culturali, che mettano in comunicazione e sinergia concittadini con pari dignità, offrendo a sinti e rom la possibilità di un riconoscimento di loro stessi come membri di una comunità che si oppone alla logica della cultura dell’assimilazione e dell’emarginazione.
La presenza dei mediatori culturali rom nei servizi socio sanitari e scolastici
La formazione e l’inserimento di mediatori culturali ha finora riguardato il consolidamento di esperienze positive di accoglienza e integrazione scolastica per lo più rivolte a comunità stabilmente insediate sul territorio milanese e provinciale.
Il forte incremento della popolazione rom straniera e la richiesta di nuove iscrizioni da parte delle famiglie di recente immigrazione, porrebbe tuttavia la necessità di estendere il ricorso a nuovi mediatori culturali che siano anche espressione dei gruppi più significativi (romeni e yugoslavi), i quali costituiscono i due terzi dell’attuale popolazione rom, consentendo alle Scuole di contrastare con maggior efficacia il fenomeno della dispersione scolastica e potendo contare sull’operato di una significativa rete sociale di sostegno.
In tal modo sarebbe possibile promuovere una effettiva distribuzione sul territorio cittadino della gran parte dei minori in età scolare garantendo un effettivo diritto allo studio.
L’insegnamento della lingua e cultura rom costituirebbe un’esperienza innovativa di forte interesse per i minori iscritti nella scuola dell’obbligo e un’opportunità di conoscenza per tutto il gruppo classe e gli insegnanti.
La lingua infatti, è il tratto identitario più forte della cultura rom ma è altresì trasmessa solo oralmente e pochi sono gli educatori rom in grado di insegnarla.
La trascrizione faciliterebbe inoltre il passaggio da un apprendimento di tipo mnemonico, agrafico, alla familiarizzazione e interiorizzazione della scrittura non vissuta solo come un veicolo di comunicazione estraneo.
Il progetto iniziale di formazione di mediatrici culturali rom si realizzò a Milano a partire dalla metà degli anni ’90 con l’obiettivo di favorire un positivo dialogo tra l’istituzione scolastica e le famiglie zingare, facilitando l’inserimento e l’apprendimento scolastico dei bambini, nel rispetto e recupero della propria identità culturale.
In particolare, considerati i pregiudizi presenti nei confronti dei Rom e dei bambini presenti a scuola, insieme al Provveditorato agli Studi venne deciso di inserire nelle classi dei mediatori culturali provenienti dai campi nomadi, che col trascorrere del tempo diventarono un punto di riferimento autorevole pei i bambini, le loro famiglie, gli insegnanti intervenendo significativamente anche sul problema della dispersione scolastica.
Un ulteriore passaggio, di particolare interesse perché integrò azioni fra loro diverse ma con obiettivi comuni, fu quello di rispondere alla richiesta, soprattutto delle giovani donne, di aveve un’occasione di lavoro e istruzione, aprendosi a un confronto positivo con la realtà esterna.
Il Corso di formazione venne realizzato nel 1993 in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano (équipe coordinata da Susanna Mantovani, allora docente di Pedagogia Sperimentale, oggi vice Rettore all’Università Milano Bicocca).
Nel 1996, le mediatrici parteciparono a un aggiornamento (della durata di 50 ore) gestito sempre in collaborazione tra Università e Opera Nomadi.
Questo secondo momento di formazione, preceduto da un’attività di ricerca (interviste e colloqui con le mediatrici e con insegnanti e dirigenti scolastici), ebbe lo scopo di monitorare l’andamento dell’esperienza, offrendo un supporto formativo in campo pedagogico e culturale e rilanciando il ruolo delle mediatrici culturali all’interno della scuola e con le stesse famiglie zingare (analisi e riflessione sulle problematiche emerse, bisogni specifici di cui prima si era consapevoli in modo generico, prospettive future di cambiamento).
All'inizio del 1998 le mediatrici culturali, sostenute dalle scuole e dai loro dirigenti, vennero incaricate direttamente dall'Amministrazione Comunale con contratto diretto, per poi passare nuovamente per un triennio in convenzione con l’Opera Nomadi e, dall’inizio del 2008 ancora una volta con contratto a termine con il Comune.
Ogni passaggio di natura "contrattuale" non fu estraneo alle difficoltà e ai contrasti politici del momento, ma nascose e accompagnò l’insidia di un’interruzione del rapporto di lavoro che da allora rimane pur sempre di carattere precario.
Nel 2005, l’allora Ministro del MIUR Moratti, oggi Sindaco di Milano e il Direttore Generale, Moioli, oggi Assessore ai Servizi Sociali ed Educativi, firmarono un Protocollo d’Intesa con l’Opera Nomadi Nazionale per la diffusione dei progetti di mediazione culturale nelle Sovrintendenze Regionali Scolastiche.
Dal 2005 al 2007, grazie ad un progetto finanziato dall’Assessorato alla Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, 15 mediatrici ebbero la possibilità si seguire dei corsi retribuiti di formazione e tirocinio (100 ore annue), con ricercatori dell’Università Bicocca, Dirigenti e Funzionari dell’Ufficio Scolastico Provinciale, conseguendo dei diplomi di scuola superiore e la certificazione per l’insegnamento della lingua italiana.
Tra il settembre e il dicembre 2007 lo stesso Assessore Moioli non rinnovò la convenzione con l’Opera Nomadi di Milano, lasciando per 4 mesi senza lavoro le mediatrici e contemporaneamente rescindendo il contratto di lavoro a 2 cooperative rom che operavano nei campi nomadi comunali. Altri 20 posti di lavoro in meno.
Dopo 23 anni di servizio, diretto e indiretto, per l’Amministrazione Comunale, l’unico Rom diplomato che collaborava con un servizio sociale di coordinamento, esprimendo uno dei più alti livelli di professionalità esistenti in Italia venne, senza alcun motivo, lasciato a casa.
Com’è immaginabile, molteplici furono le difficoltà incontrate dalle mediatrici, soprattutto nei primi anni di attività: preparazione iniziale insufficiente, richieste eccessive delle scuole che non ne compresero appieno la funzione.
Benché anche attualmente i loro compiti non siano stati del tutto definiti con chiarezza, per cui alle mediatrici si chiede contemporaneamente di provvedere all’accudimento dei bambini fino all’assunzione del ruolo di insegnanti e al mantenimento dei rapporti con le famiglie, la centralità del ruolo della "mediazione culturale" appare aver integrato significativamente l’offerta scolastica.
Le mediatrici affiancano le insegnanti agendo sull’intero gruppo classe e stabilendo dei contatti e comunicazione con le famiglie rom ma senza scaricare su se stesse un compito di mediazione che dovrebbe prima di tutto riguardare sempre il docente.
Le mediatrici oggi vantano un percorso di crescita formativa che le ha portate ad assumere una notevole consapevolezza e capacità di riflessione rispetto al loro ruolo e ai loro compiti, con cognizione di molte delle contraddizioni irrisolte, delle difficoltà incontrate, dei momenti di conflitto che hanno imparato a gestire e a superare anche grazie ad una autentica capacità di mediazione culturale conquistata sul campo.
L’esperienza condotta in questi anni ha sicuramente permesso loro di crescere umanamente e culturalmente, di confrontarsi in modo ravvicinato con il mondo dei cosiddetti gagé al di là dei reciproci stereotipi e pregiudizi e di testimoniare, all’interno della famiglia e della comunità rom un diverso ruolo della donna.
La possibilità di guadagnarsi onestamente da vivere con un lavoro qualificato, stimolante e di sicura utilità per i bambini rom oltre che per tutta la scuola, senza essere costrette alla mendicità o ad altri espedienti, è un’esperienza preziosa non solo da salvaguardare, ma da promuovere ulteriormente (per esempio aumentando il loro impegno lavorativo a scuola, oppure puntando al riconoscimento giuridico del ruolo nelle scuole dell’infanzia o nella scuola primaria).
Queste giovani donne hanno acquisito un certo grado di autonomia e indipendenza dalla famiglia, dopo un periodo di difficili rapporti perché oggetto di invidie e di rivalità da parte delle altre donne e, per quelle sposate, di difficoltà a conciliare il proprio ruolo di madri e di mogli con l’impegno lavorativo.
Esse si sono guadagnate il rispetto di molte famiglie rom proprio per il ruolo che svolgono nella scuola. Grazie alla loro presenza, i genitori affidano più volentieri i loro figli, sapendo che esse possono essere un interlocutore diretto ed affidabile, domandando direttamente ad esse oltre che all’insegnante che cosa accade ai loro bambini, come e che cosa imparino o non imparino, quali siano i problemi e le difficoltà da superare.
L’essersi impossessate di alcuni strumenti culturali del mondo alfabetizzato, senza venir meno al rispetto dei valori della cultura di origine, l’aver lavorato all’interno dell’istituzione scolastica e l’aver conosciuto regole e condizioni di vita profondamente diverse dalle loro, ha potenziato le loro capacità che, unitamente alle peculiari doti e risorse della cultura rom, ha permesso loro di assumere iniziative e di reagire anche agli aspetti di incertezza della loro condizione lavorativa.
In questi anni le mediatrici hanno acquisito maggiore autonomia ed autorevolezza, maggiore capacità d’iniziativa e di collaborazione nel rapporto con docenti e dirigenti scolastici e maggiore consapevolezza delle regole che il lavoro dentro l’istituzione scolastica comporta. Esse svolgono un ruolo cruciale nel primo inserimento dei bambini rom a scuola e collaborano con le insegnanti nel predisporre il setting dell’esperienza educativa e nell’attivazione dei dispositivi necessari all’accoglienza dei bambini.
La loro conoscenza dei bambini e delle loro famiglie, la conoscenza della loro cultura e soprattutto l’uso della lingua materna, il romanés, lingua che viene così riconosciuta ed anche valorizzata, sono i punti di forza della loro opera di mediazione culturale in tutti i contesti d’ interazione e di relazione.
Svolgono cioè un ruolo cruciale nella mediazione dei conflitti e nella prassi educativa e didattica.
Attraverso questa esperienza le mediatrici hanno acquisito anche capacità d’insegnamento, non solo nei confronti dei bambini rom, ma anche verso gli alunni stranieri e quelli con difficoltà di inserimento e apprendimento. Ciò è avvenuto affiancando le insegnanti delle classi o gestendo direttamente i bambini nell’apprendimento svolto in piccoli gruppi e nelle attività di laboratorio.
In particolare, sul piano metodologico e didattico, esse hanno compreso il valore di una didattica che si fondi:
- sull’imparare facendo e giocando
- sulla predisposizione degli spazi e sull’organizzazione degli ambienti e dei materiali
- sull’esperienza della narrazione (recupero del patrimonio orale delle fiabe e dei racconti di vita zingara)
- sullo sviluppo della creatività.
I dati dell’aumento della frequenza scolastica e dell’innalzamento degli obiettivi formativi degli alunni rom, costituiscono un’ulteriore conferma della validità del loro operato e sono, certamente, l’intervento di politica sociale più convincente attuato a favore delle comunità rom.
Sastipe (Stare bene): salute e scenari culturali
La salute è un fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività… recita l’art. 32 della Costituzione. Badate bene: "dell’individuo e della collettività (ricordava Carlo Cuomo). Abbiamo visto con quale drammaticità si pone, per le comunità zingare, la questione della salute ma anche dell’intervento coordinato dei servizi socio sanitari territoriali, così come una specifica formazione degli operatori riguardo alla realtà antropologica delle comunità e la collaborazione dei mediatori.
Le problematiche sanitarie
L’analisi dei fenomeni sanitari evidenzia aspetti di grave preoccupazione, legati soprattutto all’assenza di interventi mirati di prevenzione e cura delle principali patologie riscontrabili.
Gli indici relativi ai tassi di natalità, morbilità, mortalità rilevabili nei diversi gruppi rom e sinti sono drammaticamente accostabili a quelli dei Paesi poveri del sud del mondo e sono la conseguenza diretta non solo delle cattive condizioni di vita ma anche di un rapporto con le strutture sanitarie di base e quelle ospedaliere incerto ed occasionale.
I sistemi informativi sanitari risultano inadeguati per fornire informazioni specifiche sulle caratteristiche dell’utenza ai rom (la malattia non è un evento che investe solo il singolo individuo, bensì può diventare un problema sociale che coinvolge l’insieme del gruppo familiare esteso), mentre gli spostamenti dai luoghi di residenza impediscono di eseguire valutazioni longitudinali consistenti.
Il primo accesso nel nostro sistema sanitario per i rom è rappresentato quasi esclusivamente dal pronto soccorso ospedaliero, per la sua visibilità, accessibilità ad ogni orario, gratuità, assenza di controllo di documenti, per la possibilità di accompagnamento e di solidale permanenza accanto al paziente.
Il ricorso a tale struttura avviene dunque, secondo tradizione, nel momento di conclamata necessità: fatti traumatici o l’apparire di sintomi acuti della malattia, mentre affezioni anche gravi permangono ignorate a lungo.
I dati (pochi) di dimissione ospedaliera relativi ai ricoveri in Regione Lombardia evidenziano ad esempio un alto ricorso all’ospedalizzazione in età pediatrica, soprattutto nel corso del primo anno di vita, con una predominanza di ricoveri per malattie infettive, respiratorie e per patologie neonatali.
Più che una nomenclatura clinica si possono quindi raggruppare e classificare fattori di rischio che sviluppano patologie acute, croniche e da stress che determinano la rilevanza di malattie delle alte e basse vie respiratorie, del sistema digerente (le carie dentali sono un fenomeno diffusissimo a partire dalla prima infanzia), dermatologiche, cardio e cerebrovascolari strettamente correlate alle condizioni materiali di esistenza (situazioni ambientali malsane, vicinanza ad arterie stradali a grossa percorrenza, discariche, accumulo di rifiuti, ratti e insetti; abitudini alimentari che combinano carenze quantitative e qualitative a occasionale sovralimentazione disordinata (obesità) e abuso di fumo e bevande alcooliche; una cultura del corpo e della malattia che rende difficile il rapporto tra medicina ufficiale e zingari).
Inoltre si riscontra anche un atteggiamento delle strutture sanitarie che, riflettendo passivamente il senso comune corrente, combina incomprensione, indifferenza e atteggiamenti discriminatori: non si tenta di capire la cultura "altra", vista solo come indice di ignoranza se non di barbarie; non si prende coscienza né della gravità né della stessa esistenza del problema; spesso - anche se con numerose lodevoli eccezioni - si discrimina più semplicemente il rom che cerca il contatto con le strutture sanitarie.
Per affrontare direttamente la questione sanitaria andando al nocciolo del problema occorrerebbe dunque partire dal difficile rapporto tra la cultura del corpo e della salute delle comunità rom e sinte e la cultura specifica degli operatori dei servizi sanitari progettando percorsi di mediazione culturale tra queste due culture.
Ad esemplificazione di quanto detto i Rom e i Sinti esprimono, ad esempio, una valutazione alquanto diversa del proprio stato di salute rispetto a quanto noi siamo soliti attribuire loro sulla base di riscontri biomedici e dati statistici, non riconoscendosi come gruppo particolarmente soggetto a malattie o con una aspettativa di vita media di gran lunga inferiore rispetto alla popolazione maggioritaria.
La stessa struttura demografica delle comunità zingare ci fornisce la scelta dove indirizzare le nostre proposte di intervento: l’altissimo numero di gravidanze e di parti, quel 48 – 52% di popolazione infantile e pre-adolescenziale impongono "naturalmente" il coinvolgimento dell’area del materno – infantile.
Ma a queste ragioni obiettive se ne sommano altre.
Visto che si tratta di mediare tra due culture diverse, la scelta da effettuare è quella di investire innanzitutto sulla mediazione tra due culture femminili diverse: da una parte non la cultura "media" dei servizi sanitari ma la cultura fortemente innovativa delle operatrici dei servizi territoriali del materno – infantile (puntando soprattutto sulle operatrici dei consultori familiari e dei consultori pediatrici, da sempre tese all’ascolto attento delle utenti e, dall’altra, la specifica cultura del corpo, della sessualità, della gravidanza, dei parti e dell’accudimento – allevamento dei bambini di cui sono portatrici le romnìà, le donne zingare.
Tanto più che l’esperienza parallela della mediazione scolastica ci rivela una peculiarità femminile all’interno della cultura zingara: l’essere cioè le donne custodi della tradizione e, contemporaneamente, le più audaci portatrici del bisogno dinamico di cambiamento.
La mediatrice sanitaria rom è quindi un’operatrice che all’interno della propria cultura e comunità, da quel luogo di vita quotidiano in cui essa stessa vive, impara a rapportarsi alla cultura maggioritaria rappresentando la specificità culturale del proprio gruppo (i bisogni, i problemi e le risposte che in esso maturano) ed acquisendo dalla cultura "altra" tutto quello che può essere utilmente riportato.
In questa dinamica di interscambio culturale assumono quindi un ruolo centrale i servizi dell’area della famiglia, infanzia, età evolutiva, in relazione agli scenari demografici (soprattutto se si pensa al ben più consistente fenomeno migratorio in atto) e ai bisogni di prevenzione che modificano o meglio, costringono a ripensare il superamento di un modello di intervento solo di tipo emergenziale e per questo frammentario e una struttura dei servizi molto poco incentrata su un sistema complesso di interazioni.
Milano: un’esperienza di mediazione culturale nel consultorio familiare
Dal 1996 l’Opera Nomadi ha avviato con la ASL di Milano – Dipartimento ASSI la formazione e l’inserimento nei Consultori Familiari di mediatrici culturali sanitarie rom, dando vita a un’esperienza pilota in questo settore.
Nell’ultimo triennio questa azione ha riguardato in particolare l’intervento a favore delle donne dei gruppi romeni che intendevano recarsi al Consultorio con o senza il loro partner.
Il Consultorio è progressivamente diventato un punto di riferimento importante per le comunità di rom stranieri e italiani e, a partire da questa relazione, anche altri Servizi socio sanitari hanno iniziato ad acquisire ai loro occhi una specifica e riconosciuta fisionomia.
Nel percorso di formazione professionale le mediatrici hanno raggiunto un consistente grado di autonomia nei rapporti con i Servizi e un livello di riconoscimento da parte delle comunità Rom che ha inciso anche sulla loro condizione di donne.
All’interno dei villaggi rom la fiducia acquisita le ha messe in condizione di operare per un lavoro di sensibilizzazione sui problemi sanitari e di educazione igienica dei bambini, a partire dalla profilassi delle vaccinazioni, i controlli in gravidanza, il ricorso alla contraccezione.
La continuità ha rappresentato un valore specifico di rafforzamento dell’esperienza acquisita e di perfezionamento della sperimentazione condotta.
Ma nello specifico della cultura e della condizione dei rom essa è anche:
- una condizione essenziale per mantenere un rapporto di fiducia, faticosamente raggiunto, verso la nostra società e verso gli operatori che hanno saputo accogliere, formare e accompagnare le mediatrici nella loro attività
- una complessiva risorsa delle comunità interessate, lungo un cammino lento di integrazione che va reso il più possibile sicuro e continuo: ogni interruzione rappresenterebbe infatti una rovinosa perdita di credibilità globale e quindi un probabile abbandono dei processi avviati.
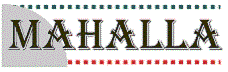



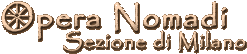
 Articolo
Articolo  Oppure
Oppure >>
>> Stampa
Stampa























 Feed RSS 0.91
Feed RSS 0.91 Feed Atom 0.3
Feed Atom 0.3
