
Si intitola così il libro che le edizioni BFS propongono, destinato non ai
cani ma ai loro padroni. È nato pensando al fatto che alcune cose, alcuni
concetti, siano molto semplici. E che in realtà non c’è nulla di complicato
nella questione “zingara”, se non le barriere mentali che noi stessi costruiamo.
Ne pubblichiamo qui l’introduzione.
Chiariamo subito una cosa. Questo libro non è destinato ai cani, ma ai
padroni dei cani. È importante dirlo. Non è scritto pensando che chi vuol capire
qualcosa in più sull’antiziganismo – ossia sui pregiudizi contro rom e sinti –
sia un cane. Anzi. Questo libro è nato pensando al fatto che alcune cose, alcuni
concetti, siano molto semplici. E che, in realtà, non c’è nulla di complicato
nella “questione zingara” se non le barriere mentali che noi stessi costruiamo.
Questo scritto, quindi, affronta alcuni luoghi comuni sugli “zingari” e cerca di
spiegare perché non hanno senso.
Gli “zingari”
Finora abbiamo scritto “zingari” tra virgolette. Cominciamo dai termini
corretti. Non si può, infatti, parlare di qualcosa e usare termini sbagliati.
Perché è sbagliato usare la parola “zingari”? Prima di tutto perché si tratta di
un eteronimo. Cioè di un termine attribuito dall’esterno, imposto. Se vogliamo
ragionare insieme e dialogare, dobbiamo chiamarci con il nostro nome.
La parola “zingaro” di per sé non è dispregiativa, come non lo sarebbe la parola
“negro”. Negro, una volta, non era un dispregiativo. Ora lo è diventato. E se il
termine “zingaro” non avesse un carattere negativo? Potrebbe pure essere
corretto se nella trattazione ci si riferisse ad un insieme di gruppi molto
eterogenei tra loro per lingua, cultura, valori, modi di vita. Se si vuole
invece far riferimento a gruppi particolari, è appropriato utilizzare termini
più specifici. Se poi desiderassimo essere aperti alla comunicazione, ancora di
più dovremmo rispettarci e chiamarci con il nostro nome. Se invece vogliamo
esprimere dei pregiudizi, va benissimo.
Se vogliamo riferirci ai gruppi presenti storicamente in Italia, dovremo parlare
di rom e sinti. Ogni gruppo ha poi denominazioni specifiche. Ci sono i rom
napulengre (di Napoli), i rom abruzzesi, i sinti piemontesi, lombardi, veneti,
teich (tedeschi), marchigiani, emiliani. E poi ancora ci sono i roma harvati,
detti anche istriani o sloveni, anch’essi cittadini italiani dal secondo
dopoguerra. Rispetto a questi ultimi, infatti, va considerato che il
rimescolamento geografico dei rom e sinti europei a causa delle due guerre
mondiali è stato forte. Durante il nazifascismo, poi, sono stati deportati e
sterminati, per non essere infine riconosciuti come vittime di persecuzione
razziale neppure al processo di Norimberga.
Negli ultimi anni ci sono anche state nuove migrazioni. Non stiamo parlando di
nomadismo, ma di migrazioni. Molti rom sono giunti da diversi paesi dell’ex
Jugoslavia, sono scappati dalle persecuzioni e dalle guerre. Recentemente molti
rom sono giunti dall’Est Europa, principalmente dalla Romania, ma anche dalla
Bulgaria e dalla Slovacchia. Migrano perché in questi paesi, oltre ad esservi
meno ricchezza economica, vi è molta discriminazione nei loro confronti. Non che
in Italia non ce ne sia, ma almeno c’è qualche opportunità in più di rifarsi una
vita.
I “nomadi”
Il termine “nomadi” andrebbe usato solamente nel caso in cui si stia parlando di
gruppi che effettivamente praticano il nomadismo. Pare un concetto nient’affatto
complicato. Eppure è un argomento difficile. Oltre il 95% dei rom e sinti
presenti in Italia non pratica il nomadismo. Anni fa i gruppi sinti si
spostavano molto di più, giravano per i paesi, praticavano vecchi mestieri. Ma
le cose cambiano.
Se non sono nomadi, perché i rom e i sinti vengono sempre etichettati come
nomadi? È uno dei temi interessanti da affrontare. Una delle ragioni dell’odio
nei confronti di rom e sinti è dovuto alla loro presunta non integrabilità. Il
nomadismo calza bene con questo concetto. In uno stato-nazione fondato sul
territorio, sulla sua difesa, sull’identità territoriale, uno che non è legato
al territorio è pericoloso. Più o meno inconsciamente il nostro ragionamento si
alimenta del fatto che questi “nomadi” non sono integrabili, che non lo sono
perché non sono legati ad un territorio. Quindi sono asociali. Sono infatti
asociali in quanto, si legge nelle carte del III Reich che giustificavano il
loro internamento e sterminio, possiedono il gene del nomadismo, il
Wandertrieb.
Come accennavamo prima, durante il processo di Norimberga non venne riconosciuto
il fatto che lo sterminio di quasi un milione di rom e sinti sia stato dovuto a
ragioni razziali. In fondo, si disse, erano stati perseguitati in quanto
asociali. Certo, ammisero i giudici, tutti gli “zingari” sono asociali per
vocazione innata. Razzialmente asociali allora? No, ma in fondo tutti sappiamo
che gli “zingari” sono asociali e non integrabili. Questa logica fa acqua da
tutte le parti, ma si comprende benissimo dove vada a parare.
È qui che lo “zingaro” cade a fagiolo. Perché in qualche modo ci fa comodo
identificarlo con il nostro peggior nemico. Sono i nomadi coloro che mettono in
pericolo il nostro ordine, coloro che ci derubano, che ci rapiscono i bambini,
che stuprano le nostre donne. Li odiamo. Oppure li vogliamo normalizzare,
rieducare. Ecco allora che siamo noi a voler portare via loro i bambini per
educarli, integrarli nelle leggi di ordine, proprietà e uniformità. Il termine
“nomade” è difficile da combattere per queste ragioni.
Ma forse i rom e sinti non si riconoscono in questo ruolo. Forse non sono i
razziatori. Forse non agiscono per danneggiare qualcosa o qualcuno. Insomma: e
se, invece, tutto fosse solo nella nostra testa?
I figli del vento
Il pregiudizio non è solo negativo. Quello positivo può essere altrettanto
dannoso. Infatti, non ci aiuta certo nella comprensione. Lo “zingaro” libero,
figlio del vento, l’artigiano nomade che lavora il rame, l’allevatore di
cavalli, appartenente al popolo anarchico per eccellenza, che balla e canta
melodie struggenti al chiaro di luna, che dorme sotto le stelle e vive alla
giornata. Sono in genere nient’altro che luoghi comuni dell’esotismo, proiezioni
romantiche di ciò che vagamente vorremmo essere. In ogni caso, sono costruzioni
arbitrarie e unilaterali.
L’idea del Wanderer (“viandante”) era centrale nel romanticismo tedesco di
inizio Ottocento. La fuga come desiderio poetico statico – desidero la fuga
perché sono incapace di realizzarla – è però ben diversa dalla fuga reale o
immaginaria, ma creativa e ricombinatoria, di chi ricerca e persegue la
trasformazione.
L’attrazione astratta ed asettica verso colui che è capace di lasciare tutto
(gli affetti, la casa, le proprietà) per mettersi in viaggio verso l’ignoto
rischia di essere il contraltare dell’odio e del desiderio di annientamento nei
confronti di chi incarna questa capacità. La staticità monolitica del III Reich,
apice dello sforzo omologante ed identitario sorge, non a caso, in seno alla
stessa società che ha generato l’idea romantica del Wanderer, a suo modo
nutrendosene. Da Wanderer a Wandertrieb il passo può essere breve.
Gli “zingari” vogliono integrarsi?
Se gli “zingari” vogliano integrarsi è una delle domande più comuni che
circolano. A chi chiede una cosa simile mi è capitato di rispondere di sì, che
in realtà la stragrande maggioranza dei rom e sinti che vivono in Italia
vogliono integrarsi. Ed è un dato di fatto. Se solo fossimo capaci di ascoltare,
ci verrebbe detto da loro stessi.
Se inoltre fossimo capaci di vedere, ci accorgeremmo che quelli che noi
etichettiamo come “zingari” sono solo una parte dei rom e sinti presenti in
Italia. Molti rom e sinti sono assolutamente “integrati” e mai si sognerebbero
di andare a dire in giro di essere “zingari”. Hanno una casa, un lavoro, le
donne non portano le gonne lunghe. Nessuna di queste caratteristiche in realtà è
fondamentale per essere rom o sinti.
Ma torniamo all’“integrazione”. Cosa intendiamo con “integrarsi”? Non facciamo
confusione. Non vuol dire assimilarsi. Se per un attimo prendiamo in
considerazione il fatto che in una società integrarsi significhi convivere
civilmente ed essere rispettati nella propria diversità, allora può andare bene.
Purtroppo le società aperte a questo tipo di integrazione sono rare. Assimilare,
invece, vuol dire pretendere dall’altro l’omologazione: un atteggiamento molto
più diffuso.
Pur essendo ottimista e considerando l’integrazione possibile in una società
aperta, quando sostengo che i rom e i sinti vogliono integrarsi provo sempre un
forte disagio. Proviamo anche solo un momento a dircelo da soli: “Sono
integrato”, “Mi sento pienamente integrato”. Deprimente. L’integrazione,
insomma, è una fregatura. Non prevede l’apertura verso l’altro, il diverso. Al
massimo lo tollera, se è disposto a sottomettersi alle leggi civili.
Famiglia e famiglie
Il nostro concetto di famiglia, poi, raggiunge il suo apice quando finalmente le
istituzioni cercano di dare risposte alle situazioni più critiche, spesso create
da loro stesse. Esempio. Un campo viene sgomberato per accorgersi solo dopo,
stranamente, che intere famiglie con bambini piccoli sono state lasciate per
strada, magari in pieno inverno. In tali casi, le istituzioni “cattive” che
hanno messo in strada le famiglie fanno un passo indietro, e subentrano quelle
“buone” – loro stesse, a volte – che per necessità devono intervenire. I bambini
vanno tutelati. Come se i bambini non fossero parte della famiglia. Come se la
tutela dei bambini non passasse attraverso i diritti dei genitori. Come a voler
dire che in realtà sarebbe meglio, per il bene dei minori, separarli dai loro
padri e madri incapaci, che forse li maltrattano e li sfruttano pure. In queste
circostanze imbarazzanti, spesso viene offerta una “soluzione” assistenziale
solo ai bambini e alle loro mamme. I nuclei familiari vengono in pratica
smembrati. I padri restano tagliati fuori e si trovano, da un giorno all’altro,
per strada. Riempiamoci la bocca di famiglia, allora, per usarla come randello e
strumento di coercizione e ordine, da tirare fuori quando è utile per poi
riporlo quando intralcia.
L’idea di integrazione di rom e sinti che coviamo nel profondo passa proprio da
questo. Dall’annullamento di ogni legame con i genitori, con il passato, con una
cultura rom e sinta che giudichiamo irredimibile.
Emergenza campi
L’assunzione dello stato di emergenza è un classico nella gestione del “problema
zingaro”. Così come sono dei classici le promesse fatte e non mantenute dalle
istituzioni. E anche la collocazione dei campi in “nonluoghi”, in prossimità di
frontiere, vicino ai cimiteri, accanto alle discariche, tra gli svincoli
autostradali. E, infine, l’utilizzo fallimentare del privato sociale per la
realizzazione di percorsi di scolarità e rieducazione.
Gli “zingari” vengono spesso trattati alla stregua di spazzatura. Nessuno li
vuole sul proprio territorio. I soldi spesi per i campi vengono buttati senza
controllo, senza alcun monitoraggio, vengono dati dalle istituzioni pubbliche al
settore del privato sociale per scaricare un problema, mai per risolverlo.
Puntualmente va a finire che la situazione non migliora per i rom, mentre il
privato sociale tende non a risolvere i problemi ma a campare di quello che ne
ricava, gestendo luoghi infami e badando bene a non criticare l’istituzione che
fornisce i finanziamenti.
Esiste un problema di logica elementare nelle politiche di “delocalizzazione”
dei rom. O si trova un luogo isolato da tutto e da tutti, oppure ci sarà sempre
qualcuno per cui la delocalizzazione è in realtà una localizzazione “a casa
propria”. Per questo si finisce sempre per destinare i campi a nonluoghi.
Andiamo al punto: chi non vuole gli “zingari” a casa propria dovrebbe ammettere
chiaramente che l’unica soluzione è sterminarli. O vogliamo ipocritamente
pensare che chi non li vuole a casa propria trovi qualcuno che li accolga
altrove?
Buone azioni o cattive pratiche?
Con queste premesse, come si può chiedere ai rom e sinti di “rispettare le
regole” in cambio della presunta concessione di diritti? Quali diritti? L’idea
di sedersi ad un tavolo e discutere con i diretti interessati per uscire da
condizioni spesso drammatiche, mettendo in gioco tutte le energie vitali
possibili, a nessuno passa nemmeno per la testa. La pianificazione nel sociale
(ovvero in ciò che ha a che fare con la dimensione della socialità, della
relazione) in Italia è quasi sempre un fallimento. Gli “zingari” rappresentano,
in questo ambito, una cartina di tornasole.
Insomma, questi esperimenti privi di strategia complessiva sembrerebbero puntare
alla rieducazione. Anche tralasciando il cupo retroterra di questo concetto, che
quantomeno rimanda ai gulag – sempre di campi si tratta – non è possibile tacere
sul fatto che la rieducazione, esplicita o implicita, è nemica del
coinvolgimento diretto. E se questo non viene perseguito è perché manca il
riconoscimento di base, quello al diritto di esistenza. Esisti, ti riconosco,
parlo con te, ti ascolto.
In questo vuoto comunicativo succede spesso che gli operatori impreparati si
fidino, per tenere sotto controllo i rom giustamente incazzati, di quei rom che
sui campi come terra di nessuno ci fanno affari. I furbi e i delinquenti che
tengono a bada coloro che si sentono schiacciati. Con il passare del tempo, i
campi diventano luoghi ingestibili, pieni di miseria e frustrazione, in cui
l’apatia è un peso che spinge sempre più in basso, là dove comandano i furbi.
Nel constatare un riprodursi perenne di problematicità, l’istituzione si
indigna. Vorrebbe che i derelitti che sta salvando fossero riconoscenti, e
vorrebbe vedere secoli di emarginazione svanire davanti ad una buona azione
caritatevole. Invece rom e sinti non accolgono la rieducazione e nemmeno
ringraziano. Magari sfasciano tutto. Nel frattempo, in genere, crescono le
pressioni da parte della “gente” e di chi alimenta l’odio per professione e, con
queste, anche l’astio e l’impotenza in chi pensava di poter risolvere il
problema. A questo punto si abbandona la via assistenzialista e si passa alla
repressione, all’espulsione, allo sgombero.
Il sospettabile mostro
Il semplice fatto di essere “zingaro” e di vivere in un campo fa cadere una
persona nella categoria dei sospettabili. Se poi un rom o un sinto infrange le
regole, i giornali, il sistema politico e l’opinione pubblica si scatenano.
Fa strano vedere come l’opinione pubblica sia scossa e spiazzata davanti al
gioco dei sospettabili. Gli “zingari” sono sospettabili. Anzi, colpevoli. Ma
quello, quello era uno dei nostri. Il marito che picchia la moglie, la signora
che uccide il figlio che frigna troppo, il figlio che uccide la madre e il
fratello, i pedofili che agiscono negli asili e tra le mura di casa.
Stranamente, mentre in Italia crescono i fatti di sangue e la violenza in
famiglia, la gente ha sempre più paura dell’altro, di chi appartiene alla
categoria dei sospettabili. Il cittadino integrato non si vuole chiedere perché
la nostra società partorisce crescente frustrazione e violenza, non si ferma a
ragionare sul tessuto sociale che si disgrega, sull’incertezza del lavoro e del
futuro, sulla banalità del successo dei meccanismi di potere che dividono i
cittadini integrati in coloro che fottono o sono fottuti, in winners or losers.
Se la paura rimane, lo sfogo si focalizza sul sospettabile, su colui che temo
possa rubarmi i privilegi accumulati, con o senza merito, o che possa rendermi
ancora più precaria ed insicura la vita.
Il nostro giudizio universale
Qualche anno fa ho lavorato ad uno studio sulla relazione tra la salute dei
bambini e le condizioni di vita in cinque campi di rom kosovari e macedoni. La
decisione di approfondire questo tema non era una mia idea, ma nasceva dal
confronto con le famiglie che vivevano nei campi: la questione della salute dei
bambini era la loro maggiore fonte di ansia. I genitori erano preoccupati per la
salute dei loro figli. Lo studio dimostrò che gli effetti di tali condizioni
sono devastanti. Non certo per colpa dei genitori. Quelle famiglie che vivevano
in campi regolari, messi in piedi dalle amministrazioni locali di cinque
capoluoghi di provincia, non potevano fare di meglio. I colpevoli erano e sono
le istituzioni, sole responsabili di un danno al futuro dei bambini rom che non
pagheranno mai.
Siamo sinceri. Possiamo dire che vi sono bambini (non necessariamente rom)
sfruttati dai loro genitori e/o da organizzazioni criminali. È tragicamente
vero. Ma attaccare i rom e i sinti su questo piano è operazione subdola e
razzista. I rom e i sinti amano i propri figli come ogni genitore. Con chiare
eccezioni, come ovunque nel mondo. Che vi siano rom e sinti che rubano è
innegabile. Il furto è sempre esistito (da sempre sanzionato) in tutte le
società e tanto più in quelle in cui è accentuato il divario tra benessere e
miseria. Poi ci sono anche gli insospettabili che rubano ben protetti in alto,
delle istituzioni (pubbliche o private) e che a molti possono persino fare
invidia per la facilità con cui accumulano successo e denaro.
La questione non è negare che vi siano rom e sinti che delinquono. Il problema è
quello di parlare di rom e sinti come dei delinquenti. Questo equivale a
stravolgere la realtà, a raccontare menzogne. I rom e sinti che vivono nei campi
sono le prime vittime di questo pensiero.
Eppure non basta mai
Intanto, comunque, i rom e sinti arrancano. Sfangarsi non è facile. La strada
per liberarsi dal peso del pregiudizio è in salita. Si può vivere come se non
esistesse? La letteratura scientifica è piena di studi sulle implicazioni
negative dell’appartenenza a gruppi emarginati, sulla difficoltà di credere
nelle proprie forze al di là dei meccanismi di oppressione. È facile chiedersi
perché i rom non escono dai campi e non trovino delle soluzioni alternative.
Ho visto un’opera di suore rifiutarsi di accettare donne rom in corsi per
collaboratrice domestica che avrebbero dato loro accesso al permesso di
soggiorno ed a un’eventuale occupazione. Le suore hanno una paura fottuta degli
“zingari” come chiunque altro. Figuriamoci un datore di lavoro medio. Un’amica
che fa la bidella ha una paura tremenda che si venga a sapere che è sinta.
Perché dovrebbe avere paura? Ha un lavoro regolare, paga le tasse. Eppure non
basta mai. Se non hai un lavoro è perché sei un disadattato, se lo hai sei
automaticamente sospettato di combinare guai. Non fa differenza se lavori, se
hai una casa, se i tuoi figli vanno alle superiori. Lo stigma dell’essere un non
integrabile continua a perseguitarti.
I rom e i sinti sono belli e brutti, intelligenti e stupidi, modesti e
arrivisti, sinceri e falsi, aperti e chiusi come tutti noi, come i nostri
parenti e i nostri vicini di casa. E si trasformano e si adattano al mondo. Ogni
volta che ho una certezza, le nuove conoscenze la spazzano via. Più vado avanti
e più mi accorgo che alle domande che mi pongono sui rom e i sinti rispondo:
«dipende». L’uomo nero è una nostra invenzione, è frutto del nostro sistema e
delle nostre proiezioni. Tocca a noi, e non a rom e sinti, comprendere cosa lo
genera e lo alimenta.
Lorenzo Monasta
Lorenzo Monasta è nato ad Embu (Kenia) nel 1969. Si è dottorato in
epidemiologia con una tesi sulla relazione tra salute dei bambini e condizioni
di vita in campi di rom macedoni e kosovari in Italia (vedi in
www.osservazione.org).
È tra i fondatori di OsservAzione, centro di ricerca azione contro la
discriminazione di rom e sinti. Sulla loro condizione ha pubblicato: Vite
Costrette (con B. Hasani, Ombrecorte 2003); Note sulla mappatura degli
insediamenti di Rom stranieri presenti in Italia (In Italia Romaní, Vol. IV., a
cura di C. Saletti Salza, L. Piasere, CISU 2004); Cittadinanze imperfette (con
N. Sigona, Spartaco 2006).
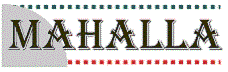




 Articolo
Articolo  Oppure
Oppure >>
>> Stampa
Stampa























 Feed RSS 0.91
Feed RSS 0.91 Feed Atom 0.3
Feed Atom 0.3
